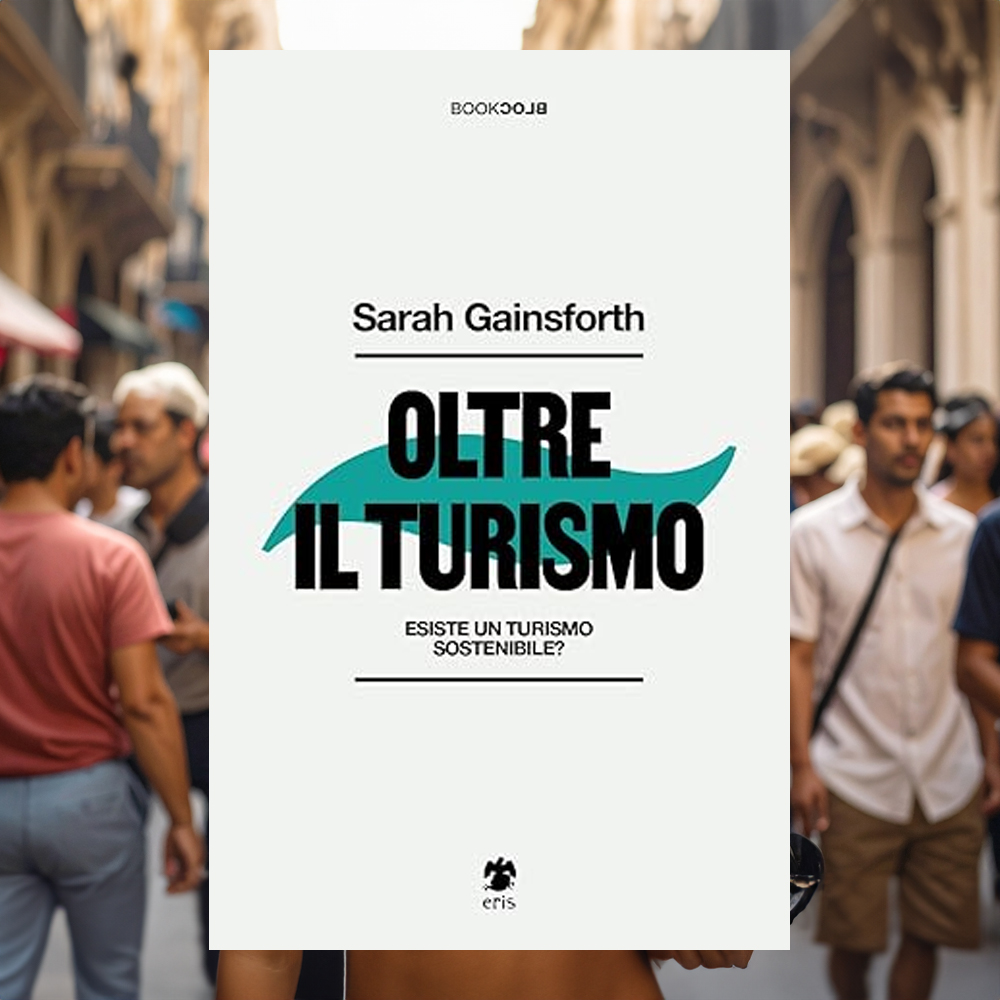
Questa città non è un albergo! Sarah Gainsforth
Questa città non è un albergo! Per un turismo sostenibile e un’ecologia dell’abitare
“Negli ultimi anni ho visto la mia professione sfigurarsi. A parte il problema della casa, questo turismo tossico porta allo sfruttamento dei lavoratori del settore. Noi guide italiane non siamo tutelate dalle grandi piattaforme digitali, che hanno sede all’estero e siamo esposte alla concorrenza di quelle straniere che hanno tariffe molto più basse delle nostre. Questo significa il montare di un turismo ancora più caotico e di massa, di bassa qualità. È stato smantellato ogni tipo di industria e di commercio al dettaglio, tutto è puntato sul binomio turismo-ristorazione: questo rispecchia una logica guadagno facile e poco lungimirante che ha portato allo sfruttamento e a strane ingerenze tra turismo, ristorazione, immobiliare e edilizia”.
Con poche e semplici parole, Edith, che è storica dell’arte e lavora da più di 20 anni a Bologna come guida turistica qualificata, riassume una realtà, l’overtourism sempre più evidente nelle nostre città. Si parla di overtourism, il troppo turismo, la turistificazione, quando, per effetto di strategiche operazioni di marketing e promozione, in una città il rapporto dei turisti supera quello dei residenti e questa diviene meta di transito non diversa da un grande parco a tema dove i cittadini finiscono per essere al servizio delle orde di viaggiatori in cerca della giusta inquadratura Instagram.
Sarah Gainsforth, ricercatrice attenta e accurata, sa spiegarlo molto bene in Oltre il turismo. Esiste un turismo sostenibile? (2020). Qui, con scrittura chiara, dinamica, ricca di dati e citazioni da fonti documentate, ricostruisce una sorta di fenomenologia del troppo turismo, coi suoi non più ignorabili costi (impatto sulla qualità della vita dei residenti, inquinamento dell’aria e acustico, consumo del suolo, volume di rifiuti urbani, collasso dei servizi di trasporto, spopolamento dei centri storici, gentrificazione di zone residenziali destinate agli affitti brevi); i suoi ricavi (tassa di soggiorno, indotto per esempio) troppo scarsi e mal distribuiti causa le fallimentari, opache, approssimate, insufficienti politiche pubbliche italiane di governance del patrimonio artistico e naturale); il progressivo conformarsi, omologarsi delle città ai gusti dei turisti, il divenire oggetti di marketing specializzato sulle piattaforme digitali.
E mentre la vita dei residenti diviene insostenibile, l’autrice si chiede se un turismo sostenibile sia possibile. La risposta è no, se la politica vede l’overtourism solo come un problema di numeri, qualità e quantità, se è goffa nel regolamentare gli affitti brevi, se si limita a imporre tasse di soggiorno esose, ticket di accesso e tariffe dei trasporti più alte. Bisognerebbe avere invece il coraggio di una politica che “ponga al centro valori umani e ambientali opposti alle diseguaglianze sociali e ai dettami del modello di sviluppo dominante”, di una radicale rivoluzione del contesto macro-economico del quale il turismo è uno dei fattori da inserire in una prospettiva di “ecologia popolare”, come parte di un tutto, dove povertà e risorse della terra, giustizia sociale e rispetto dell’ambiente finiscono per coincidere, in una crescita economica sostenibile.
Misure di contenimento dell’overtourism in tre città europee:
A Barcellona per ridurre il numero di case destinate agli affitti brevi e riportarle nel mercato residenziale, dal 2028 non verranno rinnovate oltre 10.000 licenze per appartamenti turistici e sarà bloccata la concessione di nuove licenze, ma non mancano critiche dal settore turistico e dai property manager. Da valutare l’impatto economico.
A Parigi, allo scopo di riportare alloggi sul mercato disponibili ai residenti, dal 2024 è in vigore la “legge anti-airbnb”: riduce da 120 a 90 notti l’anno la durata massima di affitto turistico, aumentano le multe per mancanza di autorizzazione e vale l’obbligo di registrazione dell’attività. Gli effetti reali sui prezzi degli affitti restano da verificare, i controlli sono aumentati ma ritenuti insufficienti.
A Berlino per contenere la pressione sugli affitti, proteggere gli inquilini e aumentare l’offerta di case a canone accessibile, è applicata l’estensione del tenant protection/cap sugli aumenti dei canoni nelle zone con “mercato immobiliare teso”, la costruzione di abitazioni sociali/sovvenzionate e la destinazione di nuovi edifici a prezzi contenuti. Le approvazioni per alloggi sovvenzionati sono notevolmente aumentate (5.100 appartamenti nel 2024) ma i limiti del cap-affitti necessitano monitoraggio e alcune leggi potrebbero essere giudicate incostituzionali.
Disposizioni del Comune di Bologna sugli affitti brevi
In Italia un Sindaco ha pochissimi strumenti per impedire a un privato di destinare un’abitazione ad affitto breve. Nel 2023 gli Assessorati alla Casa di Bologna e di altre 11 città, poi 23, hanno fatto rete e presentato al Governo cinque proposte per un Piano Casa Nazionale e contrastare il disimpegno verso le politiche urbane integrate. Gli Assessori denunciano l’impatto sull’intero sistema abitativo di un Comune a causa degli affitti brevi, in particolare sulla comunità degli studenti universitari fuori sede che vedono il loro diritto all’istruzione negato a causa dei costi dell’abitare. Al fine di monitorare il fenomeno, nel dicembre 2024 Bologna ha introdotto una nuova destinazione d’uso catastale nel regolamento edilizio: ogni alloggio destinato all’affitto breve deve essere classificato come “uso turistico” e richiedere il cambio da “residenziale” a “ricettiva extra-alberghiera”. In oltre gli appartamenti per gli affitti brevi non possono misurare meno di 50 mq.


